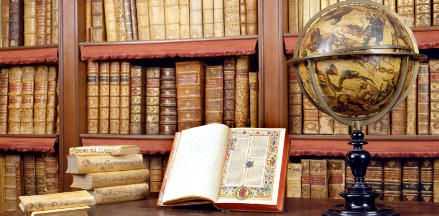Le monete ossidionali sono una tipologia di monete coniate per necessità in un periodo di emergenza, in particolare durante un assedio militare. Il loro nome deriva dal latino obsidio, che significa appunto “assedio”.
Si tratta di monete d’emergenza battute sia dagli assediati che dagli assedianti quando si verificava una grave carenza di moneta circolante. Le normali attività commerciali venivano interrotte, ma c’era comunque bisogno di pagare le truppe, acquistare provviste e sostenere l’economia interna.
Caratteristiche e Contesto Storico
Le prime testimonianze di monete ossidionali risalgono al XVI secolo, e il loro uso fu particolarmente diffuso fino al XIX secolo. Venivano coniate sia dagli assediati (per pagare le truppe e acquistare beni di prima necessità) che, sebbene più raramente, dagli assedianti.
La loro caratteristica più rilevante è l’irregolarità, sia nella forma che nel valore. A causa della carenza di metalli, le monete ossidionali potevano essere coniate con materiali non convenzionali, come il cuoio o la carta. Le zecche improvvisate producevano spesso pezzi con un valore nominale superiore al loro valore intrinseco (il valore del metallo contenuto), una pratica che le rendeva valide solo per la durata dell’assedio. Per questo motivo, venivano prontamente ritirate dalla circolazione al termine degli eventi bellici.
La tradizione romana di onorare i comandanti che liberavano truppe assediate con una corona obsidionalis o graminea è un’eco antica di questa pratica.
Le monete ossidionali sono caratterizzate da:
- Produzione improvvisata: Spesso venivano prodotte in modo rudimentale e frettoloso, utilizzando presse di fortuna e conii incisi rapidamente.
- Forma e materiale insoliti: Essendo coniate in condizioni di assedio, si utilizzavano materiali disponibili sul posto. Le monete ossidionali potevano essere fatte con l’argento o l’oro ricavato da tesori della città, o, più spesso, da metalli meno preziosi, e potevano assumere forme non convenzionali, come quadrati, rettangoli o tondi irregolari.
- Iconografia e iscrizioni specifiche: Spesso riportavano la data dell’assedio, lo stemma della città o del comandante, e indicazioni del valore e del motivo della coniazione. Ad esempio, una legenda come “Pro necessitate” o “Obsessa civitas” (città assediata) era comune.
Le più antiche monete ossidionali che si conoscano furono battute in Italia, in occasione degli assedi di Pavia e Cremona durante la Guerra d’Italia del 1521-1526. Successivamente, le coniazioni ossidionali si diffusero in tutta Europa.
- Paesi Bassi: Le monete ossidionali più note sono quelle degli assedi di Amsterdam, Leida e Groninga, coniate per pagare i difensori delle città.
- Italia: Gli Stati italiani videro numerose emissioni di monete ossidionali. Tra le più note si trovano quelle coniate a Mantova (durante gli assedi del 1629-1630, 1796-1797 e 1799), Roma (1527 e 1799), Venezia (1813-1814) e Napoli (1648). Durante la Repubblica Romana del 1849, furono attive le zecche di Roma, Ancona e Bologna. A Palmanova, assediata nel 1814, furono coniati pezzi da 25 e 50 centesimi.
- Francia: Un esempio famoso è l’assedio di Magonza del 1793, dove furono battuti pezzi in bronzo da 1, 2 e 5 sol. Durante l’assedio di Anversa nel 1814, furono emesse monete da 5 e 10 centime con il monogramma di Napoleone (N) o, dopo la sua abdicazione, con quello di Luigi XVIII (LL).
- Germania: A Jülich, nel 1610, il comandante usò l’argenteria di corte per creare monete. Durante l’assedio di Kolberg del 1807, il comandante creò dei buoni di cartone scritti a mano da studentesse.
- Inghilterra: Durante la guerra civile inglese, re Carlo I fece coniare monete negli assedi di Newark e Carlisle.
Queste monete sono di grande interesse per i collezionisti e gli storici, in quanto rappresentano una testimonianza tangibile delle drammatiche condizioni economiche e sociali vissute in momenti di conflitto.

Modoetia Numismaticae © 2014-2025