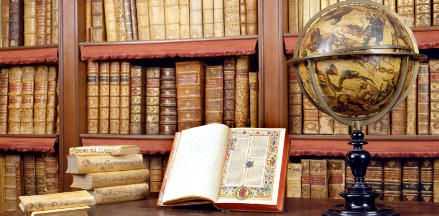Il pulvinare (o pulvinar) era il palco imperiale negli antichi circhi romani, un’imponente tribuna d’onore riservata all’imperatore per assistere ai giochi. Situato in una posizione strategica, solitamente a uno dei due estremi del diametro minore dell’arena, era l’equivalente del “palco reale” nei moderni teatri o della “tribuna d’onore” negli stadi odierni. La sua importanza architettonica era spesso sottolineata dalla presenza di un baldacchino, che ne evidenziava la sacralità.
L’etimologia del termine è affascinante. Augusto stesso tradusse la parola pulvinar con il termine greco ναός (tempio), indicando la sacralità del luogo. Il pulvinare era infatti considerato un posto riservato non solo all’imperatore, ma anche agli dèi che presiedevano e assistevano allo spettacolo. La presenza dell’imperatore su questo palco era quindi assimilabile a una vera e propria teofania, una manifestazione divina. Questo dimostra come il ruolo dell’imperatore fosse strettamente legato a quello divino, e il pulvinare era lo strumento attraverso il quale questa connessione veniva resa visibile al popolo. Era anche noto con il nome di cubiculum suggestus.
Il pulvinare si distingueva da altri posti d’onore. Quello riservato agli editores spectaculorum, coloro che finanziavano i giochi, si trovava sopra la porta d’ingresso all’arena, mentre un’altra tribuna (tribunal iudicum) era dedicata ai giudici che assegnavano i premi ai vincitori.
Oltre a questo significato specifico, nell’antica Roma il termine pulvinar aveva anche un’accezione più generale. Poteva indicare:
- Il letto imperiale, simbolo del potere e della maestà del sovrano.
- Il letto su cui venivano poste le immagini degli dèi durante le cerimonie religiose, come i lectisternia, in cui le divinità venivano invitate a “partecipare” ai banchetti e ai giochi sacri.
Secondo una recente ipotesi, proprio a causa di questo secondo significato, si ritiene che il pulvinare del circo non fosse un palco riservato esclusivamente all’imperatore, ma un lettisternio fisso per gli dèi, dal quale l’imperatore assisteva agli spettacoli solo occasionalmente. Questa interpretazione rafforza ulteriormente il legame tra il potere politico e il culto religioso, un tema ricorrente nella storia romana.

Modoetia Numismaticae © 2014-2025